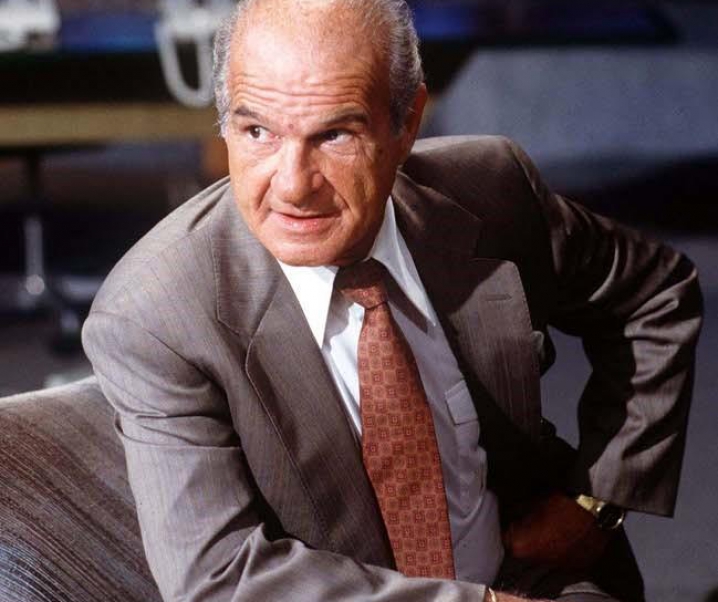È vero, e lo ammetto. A chi mi domanda se ho servito lo Stato in divisa, mi fa piacere rispondere di sì. Lo dico con sincerità, senza enfasi, ma con quel pizzico di orgoglio forse giustificato da un anno di sacrifici. È altrettanto vero che i più giovani non sanno che cosa sia il servizio militare e, forse, non sono neppure interessati a saperlo. Ma a quell’epoca, quando la leva era ancora obbligatoria, e non vi era la possibilità di evitarla, salvo casi eccezionali, il periodo di ferma voleva dire un anno lontano da casa che andava messo nel conto. Molti lo ritenevano un anno perso perché li distraeva dai loro impegni quotidiani, con la prospettiva di dover limitare i loro programmi. Altri ancora, e io tra questi, lo consideravano una pausa obbligata, da trascorrere nel modo migliore possibile, cercando di ricavarne qualcosa di utile.
«È finita! è finita!»
«È finita!, è finita!», gridavamo a squarciagola mentre lasciavamo la caserma di Macomer. «Avete fatto un misero mese di servizio di leva – ci ammonì il tenente Sforza quando ci mettemmo in marcia verso la stazione – ne avete davanti ancora undici, ricordatelo». Parole di buon senso, rivolte a chi, come me, riteneva ingenuamente di essere ormai prossimo al giorno del congedo.
Il trasferimento da Macomer alla capitale avvenne in tre tappe: treno da Macomer a Olbia, traghetto, da Olbia a Civitavecchia e ancora treno da Civitavecchia a Roma. La traversata del Tirreno fu compiuta durante la notte e non creò malesseri e inquietudini; il caso volle che ad alcuni di noi, me compreso, fosse assegnato il posto in cabina, al contrario di altri colleghi che dovettero accontentarsi del semplice posto ponte. Qualcuno lo interpretò come una sorta di ricompensa per il buon comportamento tenuto a Macomer durante il periodo del Car: non lo escludo a priori, ma non ebbi conferme in tal senso.
Appena giunti a Roma, fummo destinati alla caserma del Castro Pretorio, lungo il viale omonimo, non distante dalla stazione Termini e piuttosto vicino al presidio militare dell’aeronautica. Fu lì che ognuno di noi ebbe la conferma definitiva della propria destinazione. Per quanto mi riguarda, fui assegnato all’ufficio stampa dello Stato maggiore dell’esercito.
Castro Pretorio e dintorni
Al Castro Pretorio avevo vitto, alloggio e assistenza, ma la sede del lavoro era in via XX Settembre. Era, per fortuna, piuttosto vicina alla caserma e potevo raggiungerla a piedi, senza ricorrere all’uso dei mezzi pubblici.
L’incarico consisteva nel preparare le rassegne stampa, i comunicati stampa e di assolvere a quelle funzioni di ufficio un po’ di routine, ma necessarie per il suo funzionamento. La sveglia era alle 5.30 del mattino. La prima rassegna, comprendente gli articoli pubblicati dai quotidiani italiani a maggiore tiratura, doveva essere pronta alle 7.30, la seconda alle 10 e la terza, la meno impegnativa, nella mattinata inoltrata.
Poiché i colleghi in servizio con me non erano giornalisti, e avevano competenze diverse dalle mie, il mio arrivo in ufficio fu salutato con soddisfazione, unita a quella forma di sottile riguardo nei confronti di chi, come me, era proveniente dalla Toscana. Ripensandoci oggi, a distanza di molti anni, l’essere già giornalista di professione fu, al tempo stesso, un vantaggio e un limite: un vantaggio perché sapevo come operare e verso quale direzione muovermi; un limite perché la gerarchia militare mi imponeva di sottostare a qualsiasi richiesta mi fosse rivolta, comprese quelle che, dal punto di vista giornalistico, erano le più difficili da condividere. Ricordo, ad esempio quando, su ordine di un superiore, fui costretto a mettere mano più volte allo stesso articolo poiché, a suo dire, avevo utilizzato poche volte la lettera maiuscola, da lui ritenuta necessaria come segno di rispetto e di cortesia.
Viaggio in Campania
A parte questi piccoli contrattempi, le soddisfazioni non mancavano. Un mese dopo il mio arrivo nella capitale, il comandante del reparto, il generale Pasqualino Verdecchia, mi convocò nel suo ufficio, dicendo che mi avrebbe inviato in Campania al seguito della settimana sportiva delle forze armate: Napoli, Caserta, Salerno e Avellino erano le città nelle quali avrei dovuto lavorare. Dovevo appoggiarmi ai colleghi del comando militare meridionale di Napoli e a quelli dei vari presidi militari di riferimento incontrati durante il percorso. Partii per Napoli insieme con un gruppo di ufficiali dello Sme, tra i quali ricordo, con affetto, l’allora capitano Angiolo Palmas, conosciuto durante i mondiali militari di calcio giocati ad Arezzo l’anno prima.
Furono giorni ricchi di soddisfazione. Il gruppo di lavoro, del quale facevano parte anche alcuni colleghi delle regioni del sud, era molto affiatato. Lavoravamo con le testate giornalistiche di tutta Italia e cercavamo di offrire un servizio rigoroso e il più possibile tempestivo. Non era possibile divulgare le informazioni per via telematica e ci basavamo ancora sull’impiego dei fax, delle macchine da scrivere e del telefono tradizionale: tutti strumenti che oggi appaiono anacronistici, ma che allora ci permisero di portare in fondo il nostro lavoro come avremmo voluto.
Il no al generale
È proprio vero che le soddisfazioni, anche personali, giungono quando meno ci si aspettano. Così come accadde in occasione dei mondali militari, quando il generale Massimo Innamorati mi fornì l’opportunità di andare a Roma, anche la Campania mi dette la possibilità, stavolta non sfruttata, di un’ulteriore crescita professionale. Un alto ufficiale del Comando regione militare meridionale di Napoli, del quale non ricordo il cognome, mi aveva affidato un piccolo incarico di fiducia, al quale adempivo regolarmente ogni sera prima di fare rientro in caserma. Dovevo scrivere una serie di articoli per una rivista periodica di storia militare: avevo il compito di redarli e poi di leggerli ad alta voce allo stesso generale, prima che lui stesso mi desse l’ok per inoltrarli alla stampa.
Proprio lo stile di lettura e il timbro di voce incontrarono il plauso dall’alto ufficiale. Mi domandò per quale motivo avessi, a suo dire, una lettura bene impostata e una chiara articolazione delle parole. Gli risposi che lavoravo da alcuni anni in un’emittente televisiva privata della città di Arezzo, per la quale svolgevo servizi di cronaca e di sport, oltre alla conduzione in studio del telegiornale.
Il generale non si scompose e, in modo del tutto spontaneo, si rese disponibile a segnalare il mio nome ai dirigenti della sede Rai di Napoli per un’audizione al microfono.
Gli chiesi di poterci pensare anche se, dentro di me, si fece presto strada l’idea di rinunciare: ero militare, e questo avrebbe limitato la mia possibilità di spostamento; dovevo rientrare a Roma, e la capitale, per chi sceglie la strada del giornalismo, offre maggiori opportunità di Napoli; avevo la necessità di completare gli studi universitari, e volevo terminarli rapidamente; infine, frequentavo Francesca, un’assistente di volo dell’Alitalia, conosciuta qualche anno prima, con la quale vivevo una storia sentimentale.
Tutti buoni motivi, almeno per me, per telefonare al generale e declinare la proposta offerta.
Ripartii da Avellino convinto di avere fatto del mio meglio. Ripresi il pullman per tornare a Roma stanco ma contento. Mi attendevano altre avventure.
Il seguito alla prossima.